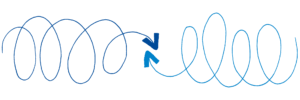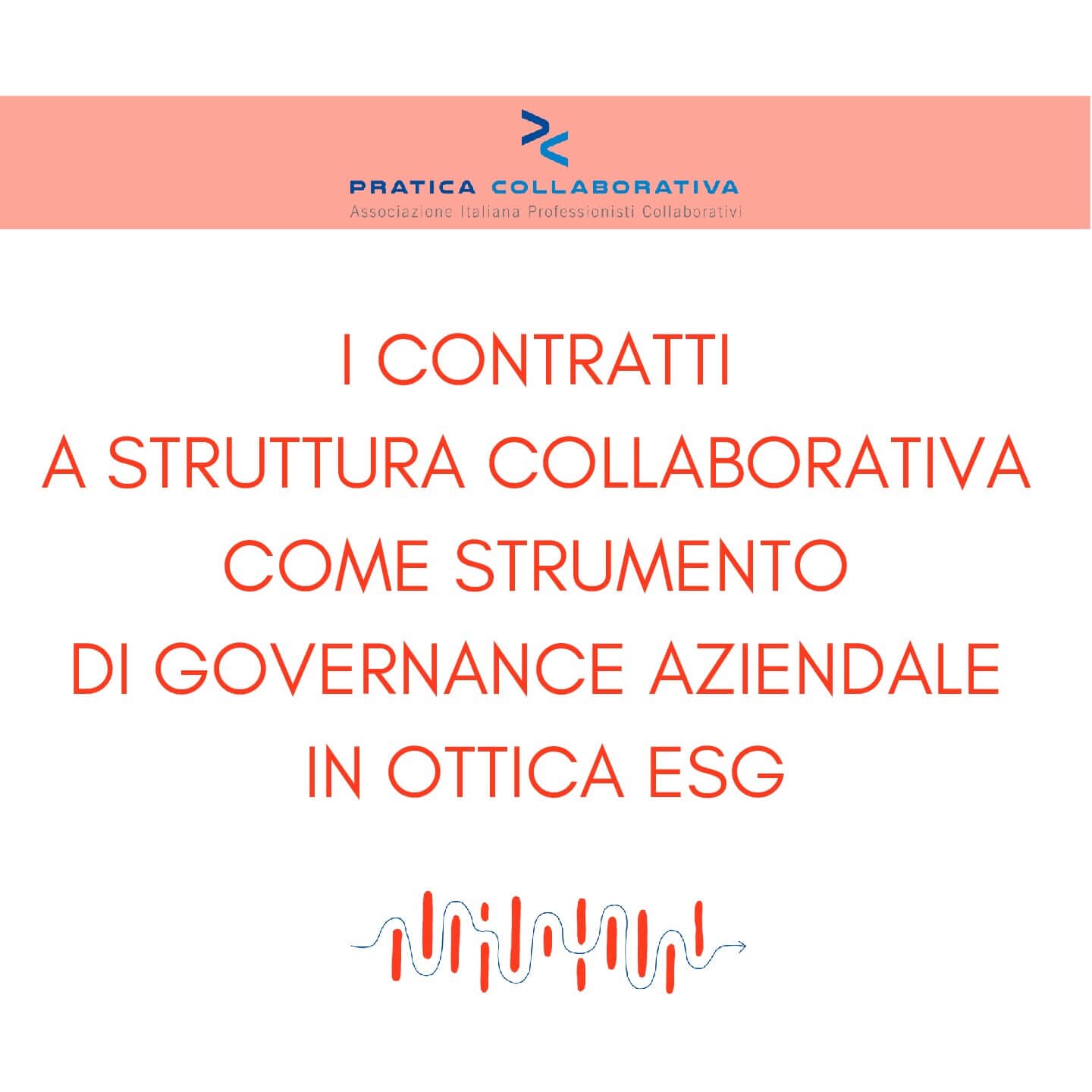La Governance aziendale in ottica ESG
Nel grande dibattito sugli strumenti applicativi dei tre pilastri di sostenibilità ESG (E_ environment, S_ social e G_governance), in tanti sono concordi sull’importanza dell’impatto di quelli legati alla governance; tuttavia, poche ne sono le declinazioni pratiche.
Lo scenario non cambia neppure osservando le matrici delle principali metodologie di valutazione d’impatto: lo scarso sviluppo di KPI (Key Performance Indicator) sul versante della governance è un segnale evidente della difficoltà di individuare strumenti innovativi, da cui fare emergere indici d’impatto anch’essi ad elevata connotazione innovativa.
Si tratta, in effetti, a livello microeconomico (in cui la struttura della PMI italiana si pone come nostro possibile modello di riferimento) di individuare – e coraggiosamente percorrere – strade che consentano di mettere a sistema i domini di valore (quali democrazia partecipata, beni relazionali, trasparenza, condivisione delle decisioni, solidarietà e giustizia) con le macrofunzioni aziendali interne ed esterne di riferimento (governance in senso stretto, amministrazione, vendite, risorse umane, supply chain e clienti).
Strade che possono rappresentare, nel momento in cui coinvolgono la governance interna aziendale, veri e propri processi di cambiamento, sviluppo e, appunto, nuovo impatto in ottica ESG.
I contratti a struttura collaborativa.
In questa prospettiva, uno strumento di processo che merita certamente di essere valorizzato è quello dell’implementazione dei contratti a struttura collaborativa.
Per quanto concerne la loro natura giuridica si tratta di contratti d’impresa – tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli tipicamente di durata con clienti, fornitori, distributori o rete vendita se esterna – che mettono al centro della propria genesi il coinvolgimento effettivo dei diversi portatori d’interesse.
Tanto nell’avvio quanto nella gestione delle fasi del processo di strutturazione del contratto, infatti,
la co-partecipazione di diversi stakeholders (soggetti interessati per categorie variabili in base alla funzione tipica del contratto in corso d’opera) rappresenta un elemento essenziale e caratterizzante.
Da questa partecipazione allargata – del tutto insolita e decentrata rispetto alla genesi tipica del contratto redatto da un legale – non può che emergere un assetto bilanciato degli interessi coinvolti a patto che, a movimentare le fasi del processo, siano chiamati professionisti capaci di applicare tecniche di emersione degli interessi e di negoziazione di tipo collaborativo e per i quali, quindi, il necessario bagaglio giuridico rappresenti condizione sì necessaria ma non sufficiente.
Nell’ottica dell’implementazione del contenuto, i contratti a struttura collaborativa si caratterizzano, in particolare e tra gli altri, per l’aspetto di auto_ regolamentazione della fase patologica dell’esecuzione del contratto. Allontanandosi da alcuni schemi classici del diritto, quali la previsione di penali, condizioni risolutive per inadempimento e simili, le clausole risultano strutturate per traghettare le parti verso un’auto gestione del conflitto.
L’obiettivo è la salvaguardia della relazione contrattuale e, ove ciò non sia possibile, exit_strategy condivise e comunque l’esclusione del ricorso a procedimenti contenziosi.
Per raggiungere tale obbiettivo, che potrebbe definirsi di “stabilità dinamica”, i contratti a struttura collaborativa, non tendono a determinare soluzioni delle potenziali contrapposizioni tra le parti soltanto in termini di diritto, ma si concentrano, ancora una volta in modo del tutto innovativo, su processi di gestione preventiva consapevoli e responsabilizzanti dell’apporto di ogni soggetto coinvolto.
Specifici ambiti di applicazione.
I contratti a struttura collaborativa possono, inoltre, validamente considerarsi strumenti di gestione adeguati nell’ottica degli standard ISO 44001:2017 in materia di Relazioni commerciali collaborative, anche con riguardo alle linee guida UNI ISO 44002:2019 per la loro implementazione.
Una delle finalità specifiche e dichiarate dello standard è, infatti, la pianificazione della creazione di valore da parte delle strutture organizzative di tipo collaborativo unitamente alla misurazione del valore creato. L’assunto della norma è che la gestione collaborativa dei rapporti generi valore (cioè impatto misurabile di segno positivo in ottica ESG) nell’ecosistema di business dell’impresa.
Tale valore, sempre nell’assunto della norma ISO, risulterà ovviamente tanto superiore quanto maggiore sarà il grado di maturità e sviluppo degli strumenti collaborativi applicati: è sufficiente osservare la matrice D allegata agli standard per concludere che i contratti a struttura collaborativa si pongono al massimo grado di maturità per ciascuna delle dimensioni aziendali osservate, veicolando così un’elevata creazione di valore.
In conclusione: le potenzialità dei contratti collaborativi in ottica ESG
Le potenzialità e il valore dei contratti collaborativi in ottica ESG sono quindi davvero molteplici:
– l’attivazione del processo risponde ad una logica multi_stakeholder e può essere osservato per ciascuno di essi in funzione di diversi domini di valore;
– hanno un evidente e percepibile impatto sui temi di governance interna, dal momento che a veicolare il processo possono essere validamente chiamati i soggetti a cui la governance aziendale è in effetti affidata e ciò può coadiuvare una gestione stabile e duratura dell’impresa;
– consentono la strutturazione di KPI d’impatto, variamente declinabili in base alla struttura contrattuale osservata, alla dimensione dell’impresa e al contesto in cui vengono applicati;
– ancor più nello specifico, possono rivelarsi strategici nella delicata gestione dei temi ESG di supply chain;
– infine, a fronte di una progressiva applicazione aziendale, rispondono anche a plurime esigenze legate ad obiettivi strategici di medio e lungo periodo (tra cui fidelizzazione, miglioramento della reputazione, creazione proattiva e mantenimento di reti d’impresa).