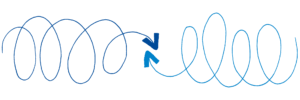Il nuovo libro di Forrest S. Mosten e Adam B. Cordover “Building a Successful Collaborative Family Law Practice” è una prelibatezza. Per chi ha sviluppato un palato collaborativo, è un tre stelle Michelin da assaporare con calma capitolo dopo capitolo o, meglio, portata dopo portata.
Dopo vent’anni di Pratica Collaborativa, dove molto è stato studiato e sperimentato sul campo, Mosten ed altri 24 coautori, tra i quali molti studiosi di spicco del movimento, fanno il punto su modelli, formazione della squadra, funzionamento del team ed altro ancora. Il loro lavoro mette letteralmente “le ali” alla Pratica Collaborativa, dando nuovo impulso ad un metodo che vuole restare al passo con i tempi e con le trasformazioni in atto nella professione forense, oltre che diventare economicamente accessibile per ogni cliente dello studio tenendo conto sia delle sue inclinazioni che del budget disponibile.
Sappiamo che gli accordi si possono raggiungere con vari metodi di ADR. Quindi la chiave di lettura della PC non è la mera soluzione stragiudiziale della lite, bensì la garanzia di un metodo che offre alle parti la possibilità di trovare soluzioni durature ed accordi la cui qualità sarà per loro sensibilmente diversa perché, aiutati da professionisti educati al metodo non avversariale, avranno avuto la possibilità di sanare (in parte o del tutto) il conflitto mentre costruivano delle soluzioni su misura per la loro famiglia guardando al futuro.
Tutto questo è possibile perché un’efficace soluzione ai problemi della coppia in separazione ha davvero poco a che fare con la Legge e molto a che fare con la relazione e la sostenibilità economica sia a breve che a lungo termine.
Uni, multi e inter-disciplinare
Sappiamo che anche altri metodi di ADR fanno un uso “multidisciplinare” delle professionalità ricorrendo ad esempio all’intervento di professionisti, sia neutrali che di parte, che mettono a disposizione dei clienti o degli avvocati un contributo tecnico che è specifico delle loro singole professionalità.
Nella sua espressione più innovativa il metodo collaborativo permette invece ad un team di lavorare sui diversi aspetti del conflitto in maniera “interdisciplinare” mettendo in campo professionalità che partecipano direttamente allo scambio di informazioni e vanno ad affiancare, e talvolta a sostituire, quelle legali permettendo, attraverso la conoscenza delle caratteristiche di quel particolare conflitto, l’applicazione delle migliori tecniche per la sua risoluzione.
Non bisogna però dimenticare che nella sua espressione più ridotta la PC si è avvalsa anche di un modello unidisciplinare (il classico caso di un team ridotto alla sola presenza degli avvocati collaborativi e delle parti). Altri modelli appaiono chiaramente misti, con la costituzione di una squadra interdisciplinare che può fare ricorso ad altri professionisti che contribuiscono alla soluzione in modo multidisciplinare (il caso dell’Allied Professional della Florida ne è un esempio tipico). I molti diversi modelli che incontriamo, sia ripercorrendo la storia della PC che spostandoci geograficamente da uno stato/continente all’altro, sono spesso dovuti a motivazioni storiche legate all’effettiva disponibilità di diversi professionisti in quel determinato periodo ed ambito geografico ed alle preferenze di chi ha promosso ed insegnato la PC a quella comunità.
Dopo aver parlato con Mosten del modello ideale ho compreso che “il” modello ideale erano in realtà “i” modelli ideali e che il mio bisogno di ricercare un unico modello ideale e le discussioni che vi ruotavano intorno, così come il tentativo fatto da alcuni autori di catalogare i vari modelli esistenti, erano forse legati al vecchio paradigma ed alla necessità che noi avvocati abbiamo di ricostruire la nostra “comfort zone” in un procedimento. Una rigidità professionale che, una volta individuato un procedimento, ci porta poi a difenderlo ed a promuoverlo anche a discapito di soluzioni diverse che per altri sono egualmente soddisfacenti. Può però anche trattarsi di un’ortodossia necessaria quando si crea qualcosa di nuovo.
Ma, come ci domanda Ron Ousky nel capitolo 13 del libro, quanto quest’ortodossia può aver rallentato la diffusione della Pratica Collaborativa e limitato la formazione delle squadre?
Credo che, se vogliamo creare delle soluzioni su misura centrate sulla famiglia, non abbiamo più bisogno di rispondere a questa domanda perché è oramai evidente che ci dovrà essere un bilanciamento tra la sostenibilità emozionale ed economica per i clienti da un lato, e l’efficacia del modello scelto per la soluzione del loro caso dall’altra. Quindi anche il modello dovrà essere su misura per ogni coppia, e va da se che da ora in avanti si dovrà avere particolare cura nella formazione del team e nella conseguente scelta del modello e del suo funzionamento pratico, oltre che nel metodo che pure è carattere distintivo della PC.
L’approccio dell’avvocato collaborativo al modello varierà molto a seconda della sua formazione, mentalità, esperienza, abilità, competenze, e di quello che ritiene essere economicamente sostenibile per il cliente. La tendenza dei professionisti collaborativi più capaci è senz’altro quella di offrire un team completo. Quindi, nel corso delle nostre conversazioni, Mosten non ha avuto dubbi nel confermarmi che un team ideale potrebbe prevedere, oltre ad un avvocato per parte, anche un coach per parte, ed inoltre un facilitatore, un commercialista neutrale ed uno psicoterapeuta dell’età evolutiva, e che le soluzioni migliori si raggiungono quando il team è presente a tutte le riunioni e la comunicazione è maggiormente protetta. Tuttavia, con la pacatezza e l’equilibrio che gli sono propri, mi ha fatto notare che alcuni clienti potrebbero sentirsi sopraffatti dall’affollamento delle riunioni, altri potrebbero non potersi permettere un team completo sempre presente e disponibile, altri ancora potrebbero lamentare l’inutilità (e il costo) di un professionista che, nel corso di una riunione, non abbia potuto contribuire ad un determinato argomento in quanto non di sua specifica competenza.
Il modello transdisciplinare flessibile.
Esaminando i modelli più recenti, la “flessibilità” sembra essere il minimo comune denominatore nella ricerca di nuove soluzioni.
Soluzioni su misura centrate sulla famiglia necessitano quindi di un modello flessibile (già adottato da varie comunità, si pensi a MELCA ed al Minnesota) dove il numero dei professionisti coinvolto nel team possa variare, in aumento o in diminuzione (anche nel corso di uno specifico caso), a seconda delle questioni da trattare e dove anche la presenza dei professionisti alle riunioni possa variare a seconda delle necessità (prevedendo anche la possibilità di una partecipazione parziale, o un’assenza, o anche una presenza nei locali attigui in modo da non pesare economicamente ma poter intervenire immediatamente laddove necessario).
Fino ad oggi abbiamo sentito parlare della “danza del professionista collaborativo”. Questa è chiaramente “la danza del modello”.
Ma questa soluzione necessita a mio avviso di due cose:
- un approccio transdisciplinare (si pensi ad esempio a quei casi in cui fungono da facilitatori a rotazione gli avvocati o uno dei neutrali e non necessariamente lo psicologo o il coach) che rafforzi la posizione centrale dei clienti con la diffusione dei ruoli dei singoli professionisti, il che evidentemente implica non solo una comune formazione ai principi della Pratica Collaborativa, ma anche una formazione incrociata di competenze e di pratica congiunta, oltre che una maggiore introspezione ed auto-consapevolezza che ci aiutino a risolvere problemi personali che potrebbero impattare negativamente sul funzionamento del team;
- la disponibilità degli avvocati a “fare un passo indietro”, accettando che in alcune riunioni potrebbe essere proprio la loro presenza ad essere inutile (pensate al caso in cui le questioni da trattare riguardino la genitorialità, o la comunicazione, o la raccolta di dati contabili ecc.).
Il segreto sta nel soddisfare il cliente con il modello di pratica che meglio si attaglia ai suoi valori e bisogni. Il tutto partendo da un modello ipoteticamente completo ed organizzandolo a seconda dei bisogni della famiglia, nel rispetto delle risorse disponibili e nell’ottimizzazione degli interventi di ciascuno, in modo che non si debba rinunciare ad alcun professionista né appesantire il lavoro con presenze non necessarie.
Come si chiama questo nuovo modello? Ronald Ousky preferirebbe non dargli un nome, per non creare delle inutili divisioni perché a suo avviso i nomi e le categorizzazioni di tutti i modelli fino ad oggi adottati hanno creato solo difficoltà. Se proprio necessario vorrebbe chiamarlo il “modello centrato sul cliente” perché questo nome sintetizza la tecnica da seguire per la costruzione del team. Avvedendosi però del fatto che ciascun altro diverso modello ritiene a sua volta di essere centrato sul cliente, si risolve a chiamarlo “modello flessibile”.
Verso la pratica transcollaborativa?
Nel futuro dobbiamo garantire l’accessibilità della PC a tutte le famiglie, e lo possiamo fare resistendo all’ortodossia ed adottando la flessibilità nella formazione e gestione delle squadre. A mio avviso, il modello flessibile non deve essere considerato un punto d’arrivo bensì un punto di partenza per lo sviluppo di una squadra transdisciplinare. Solo in questo modo la PC potrà essere rivoluzionariamente trasformativa anche in tutte le ipotesi in cui, per ragioni diverse, non sarà stato possibile utilizzare l’intero team.
Possiamo quindi smettere di chiederci quali e quanti siano i modelli della Pratica Collaborativa. Uno, nessuno, centomila? La risposta ci accomuna tutti senza divisioni: il modello è unico e forse lo è sempre stato, con centomila (in realtà infinite) declinazioni adatte per ogni famiglia e situazione.
Trento, 29 aprile 2019
Avvocato Elisabetta Valentini – Professionista Collaborativo