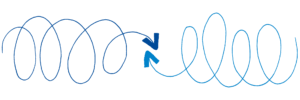Il 23 febbraio abbiamo pubblicato la prima parte dell’articolo di Cristina Rey dal titolo “La Pratica Collaborativa a vantaggio delle famiglie problematiche”.
Ecco oggi la seconda parte nella quale la nostra socia penalista analizza come il legislatore italiano ha affrontato il tema della violenza domestica, evidenzia le criticità della precipitosa ratifica della Convenzione di Istanbul ed ipotizza l’uso, sia pur mai generalizzato e sempre prudente ed attento, della Pratica Collaborativa in alcune di queste situazione evidenziandone i possibili migliori risultati rispetto alla gestione contenziosa.
LA PRATICA COLLABORATIVA A VANTAGGIO DELLE FAMIGLIE PROBLEMATICHE (C. Rey, seconda parte)
IPOTESI DI UTILIZZO DELLA PC NEI CASI DI DISGREGAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI IN CUI UN COMPONENTE È MALATO PSICHIATRICO O MENTALMENTE INSTABILE, ABUSA DI SOSTANZE O PONE IN ESSERE VIOLENZA DOMESTICA
L’Italia e la violenza domestica
Negli ultimi 20 anni l’Italia ha avviato una vera e propria rivoluzione giuridica – che per certi aspetti ha anticipato e favorito la corrispondente evoluzione culturale – in tema di violenza contro i soggetti deboli.
Il pilastro su cui si fondano le riforme interne è costituito dall’abbandono della posizione per cui gli episodi di sopraffazione all’interno delle mura domestiche sono un fatto privato, quindi nella totale disponibilità delle parti, a favore dell’idea che la violenza domestica è un fenomeno di rilevanza collettiva, donde il potere dello Stato di intervenire nonostante l’inerzia o il contrario volere dei soggetti che ne sono protagonisti.
Il cambio di paradigma è stato inaugurato con la riforma dei reati sessuali del 1996, che ha avuto il pregio di riconoscere che le offese sessuali danneggiano la persona e non – come si riteneva in precedenza – la morale. Sono seguite innumerevoli modifiche di legge che hanno aggiornato sia il decalogo dei reati – introducendo ad esempio i delitti di stalking e di mutilazioni genitali femminili, nonché inasprendo le pene per i maltrattamenti in famiglia – che il processo, che oggi ha regole sue proprie ed appare come una sorta di “rito speciale” all’interno delle generali regole del codice di procedura penale.
Dal canto suo, grazie alle riforme il Giudice civile può oggi disporre un ordine di protezione contro il coniuge o convivente che pone in essere atti di abuso familiare, anche non integranti fattispecie di reato.
Sono stati infine introdotti nuovi procedimenti amministrativi, in cui il Questore può emanare provvedimenti analoghi alle misure di prevenzione personali e che consentono, in specifiche ipotesi, l’ammonizione del presunto autore di fatti violenti in ambito domestico.
Sul piano sovranazionale, vi è da segnalare che l’Italia è stata uno dei primi Stati firmatari della convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta della violenza contro le donne e violenza domestica, meglio nota come convenzione di Istanbul, approvata nel 2011 .
Le considerazioni che possono trarsi dall’analisi di questo percorso giuridico sono nel senso della indubbia presa di coscienza della gravità del fenomeno della violenza domestica, nonché della necessità di un intervento di carattere pubblico mirato a contenerne le conseguenze pregiudizievoli.
Il difetto – se così si può definire – di questa impostazione normativa è che gli strumenti a tutela delle persone deboli risultano poco adattabili all’evoluzione del conflitto di coppia.
Tutti i recenti interventi del Legislatore sono infatti accomunati dallo sforzo di sottrarre la persona offesa alla pressione psicologica derivante dalla possibilità di cambiare idea. La ragione di questa scelta è solitamente indicata nella considerazione che la vittima di violenza, a cui fosse riconosciuto il potere di estinguere il reato mediante il ritiro della querela, sarebbe facilmente pressata e indotta dall’autore di reato a rinunciare alla sua punizione, e pertanto la legge deve difenderla da questo tipo di manipolazioni.
La stessa Convenzione di Istanbul percorre questa strada (artt. 55 Convenzione). La fonte internazionale peraltro si spinge ben oltre, ponendo dei limiti anche alle iniziative extragiudiziali e, nella specie, vietando “i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione” (art. 48 Convenzione).
Vediamo che cosa comporta questa scelta di politica legislativa.
Convenzione di Istanbul versus ADR?
Come si è detto, l’Italia ha ratificato a tamburo battente e con larga maggioranza parlamentare la Convenzione di Istanbul . Ritengo peraltro che tale entusiasmo – comprensibile sotto il profilo dei principi – non abbia consentito un’adeguata valutazione delle conseguenze che la norma di cui all’art. 48 avrebbe causato nel nostro sistema interno.
Innanzitutto, è indubbio che il nostro ordinamento prevede, ancora al momento attuale, istituti che contemplano forme di ADR utilizzabili anche nelle ipotesi di relazione domestica connotata da violenza.
In primis rammento la norma che regola gli ordini di protezione (art. 342 ter c.c.) e che conferisce al Giudice civile il potere di disporre l’intervento di un centro di mediazione familiare, evidentemente nella prospettiva di ridurre il conflitto tra i partner.
Mi chiedo però se la negoziazione assistita, la presentazione di condizioni di separazione consensuale per l’omologa del Giudice o, ancora, di un ricorso congiunto per divorzio – istituti che presuppongono una trattativa tra le parti e/o i loro avvocati con l’obiettivo di evitare il contenzioso, e perciò nella sostanza assimilabili alle ADR – violino il disposto di cui all’art. 48 della Convenzione ove utilizzati tra partner autori e vittime di violenza.
Quale l’interpretazione autentica del Legislatore? La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nell’istruttoria legislativa che ha accompagnato uno dei progetti di legge poi confluiti nella legge 119/2013 c.d. “contro il femminicidio” (relazione del 20 maggio 2013) analizzando l’art. 48 della Convenzione di Istanbul osserva che: “L’ordinamento italiano non conosce metodi alternativi di risoluzione dei conflitti nel settore penale, anche in considerazione dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Nel settore civile, con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è stata disciplinata la possibilità della mediazione nelle controversie civili (quindi: anche quelle per risarcimento danni) e commerciali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato incostituzionale l’obbligatorietà della mediazione”.
La Commissione, in altre parole, non ha ritenuto necessaria alcuna modifica della normativa interna per raccordarla con la fonte internazionale, posto che nel nostro processo penale la mediazione non è contemplata e, quanto ai processi civili, dove potrebbe essere disposta dal Giudice la mediazione per il risarcimento del danno derivante dalla violenza domestica (sic!) è intervenuta la Consulta che ha dichiarato illegittima la mediazione obbligatoria.
Questa posizione evidenzia, a mia sommessa opinione, un travisamento della norma internazionale. Il nodo a cuore del Consiglio d’Europa non era certo la mediazione civile sul danno, bensì la condizione di rischio insita in altri strumenti di ADR, quali ad esempio la mediazione familiare o la mediazione riparativa, che lavorano sulle emozioni e aspettative della persona, sulla sua sofferenza, sulla prospettiva di un futuro accettabile, ove una delle parti risultasse in condizione di sudditanza psicologica dall’altra.
L’uso possibile della Pratica Collaborativa
Personalmente ritengo che l’interpretazione della Convenzione non vada estremizzata e che il divieto introdotto non riguardi quei metodi, pratiche o istituti in cui le parti si confrontano liberamente con lo scopo di cercare un’alternativa alla decisione del Giudice. La Convenzione intende vietare l’obbligo per le parti di ricorrere a tali metodi, e ciò per scongiurare quelle situazioni in cui la parte debole è costretta a confrontarsi col suo aggressore, ma non si sente abbastanza tutelata o non è pienamente tutelabile.
Se tale premessa è condivisa, allora il punto non è tanto se è consentito o vietato mediare, ma quali sono le scelte di opportunità del professionista a cui viene richiesto un intervento che aiuti le parti di conflitti violenti, molto accesi o malati ad evitare il contenzioso.
Sul punto vi sono storicamente posizioni contrapposte, che vale la pena riassumere.
Alcuni Autori sono apertamente contrari alla mediazione familiare in queste ipotesi, ed hanno addirittura descritto un atteggiamento sociale negazionista rispetto al fenomeno in sé della violenza domestica, o comunque complice con la strategia che il maschio violento pone in essere per nascondere i propri comportamenti.
Secondo questa posizione la mediazione familiare, ispirandosi ad un modello di responsabilità diffusa, costituisce una doppia violenza sulla donna in quanto richiede che le parti si concentrino sul presente e sul futuro, senza la possibilità di rievocare le sofferenze del passato. Viene inoltre chiesto alle parti di ritirare tutte le denunce e di sospendere le iniziative giudiziarie in corso. Alla donna in questo modo viene impedito di esprimere la sua rabbia o paura nell’interazione con il partner violento, o anche solo di ottenere giustizia per quello che è stato. D’altro canto, l’aggressore avrà un vantaggio in termini di risultato giudiziario, ed inoltre potrà utilizzare gli incontri di mediazione per riallacciare i rapporti con la vittima e continuare a perseguitarla.
Un’altra posizione , non troppo dissimile, critica fortemente la mediazione riparativa – pratica in cui si invita l’aggressore a mettersi nei panni della vittima affinché comprenda la sua sofferenza e si indirizzi verso una condotta riparatoria in suo favore – in quanto inadatta a quelle relazioni interpersonali connotate dal controllo di una parte sull’altra attraverso un meccanismo di esercizio del potere. “Difficilmente in questi casi l’uomo sarà in grado di comprendere e riconoscere il danno arrecato e cambiare il proprio comportamento, poiché si tratta di uomini che attraverso il controllo e l’esercizio del potere vogliono mantenere uno status quo”.
D’altro canto la vittima potrebbe ricevere la falsa illusione di essere compresa nella sua sofferenza e che il comportamento del suo aggressore si interromperà, con conseguente aumento per lei del rischio di rimanere nuovamente vittima di sopraffazione. Da ultimo, non vanno sottovalutati gli effetti della “sindrome di impotenza appresa” causata dall’esposizione prolungata alla manipolazione, per cui la donna si percepisce come incapace di fare o pensare qualsiasi cosa. In quei casi, non si può certo ritenere la vittima libera di autodeterminarsi.
Altri Autori sono, invece, maggiormente possibilisti e salutano le ADR come un’opportunità in più per risolvere positivamente anche questi conflitti familiari.
Si osserva, in modo per me condivisibile, che esistono diverse forme di violenza e diverse gravità nei comportamenti, a cui è opportuno che corrispondano scelte a loro volta diversificate. Esiste la violenza ripetuta, adottata quale stile relazionale usuale, radicata nel comportamento della coppia e manifesta per tutto il corso della relazione; esiste però anche la coppia felice che muta il proprio stile relazionale nel momento in cui affronta il difficile nodo della separazione; in altre parole, gestisce malamente la crisi di coppia. Questi sono i due estremi di una linea ideale, in cui si rinvengono anche situazioni intermedie.
Il nostro ordinamento non fa differenza tra queste ipotesi, se non ai fini dell’entità della pena: si tratta pur sempre di condotte idonee ad integrare reato o comunque a far scattare la tutela pubblicistica di cui si parlava poc’anzi. Diversa, invece, è la situazione di fatto corrispondente e, soprattutto, la fluidità del contesto relazionale in cui è maturato il comportamento.
Le posizioni rigide contro la mediazione nelle famiglie a rischio non tiene conto del fatto che, proprio nelle ipotesi in cui l’agito violento o manipolativo sono recenti, poco gravi e scarsamente pervasivi, e quindi non in grado di influenzare in modo significativo la capacità di autodeterminazione della vittima, il conflitto potrebbe godere di una migliore capacità di evoluzione in senso positivo se tenuto fuori dalle aule di giustizia.
È quindi importante, pur senza smentire la rilevanza pubblica del fenomeno, garantire alle coppie una maggiore autonomia di scelta.
In effetti, ciò che è importante evidenziare è che l’Ordinamento interviene “fotografando” una situazione di fatto in un determinato momento storico, in una visione a due dimensioni che non tiene conto del fattore tempo, ossia del fatto che le relazioni umane hanno una loro naturale capacità di evoluzione che si snoda in tempi anche lunghi, ma che comunque le rende più simili ad un albero nel corso delle stagioni che non a un dipinto dello stesso albero.
L’enorme valore aggiunto delle ADR è che offrono un’ottima aderenza a tale cambiamento, potendo seguire la persona per come è in quel momento, introducendo man mano gli adattamenti opportuni, senza le limitazioni discendenti dalle regole e/o dal decorso del tempo .
In particolare la Pratica Collaborativa, se opportunamente organizzata, può dare delle garanzie ancora superiori rispetto agli altri strumenti di ADR.
Innanzitutto, un team composto da professionisti con specializzazioni diverse effettuerà la valutazione preliminare se il caso è adatto o meno alla Pratica. Ciò consentirà di approfondire a tutto tondo l’analisi dei rischi di cui si è parlato sopra.
Si potranno inserire nel team collaborativo figure ulteriori, diverse da caso a caso, che apporteranno le conoscenze necessarie per comprendere la natura del conflitto e/o della patologia.
L’esperto delle relazioni si esprimerà in modo competente sulla modalità – bilanciata o sbilanciata – della relazione in essere tra i partner; ma anche gli avvocati avranno un ruolo determinante, perché saranno loro a concentrare l’attenzione sulla prospettiva della parte, segnalando il disagio di chi non si sente compreso o al sicuro ed eventualmente “difendendo” la sofferenza, o mettendo in guardia il team da eventuali tentativi manipolatori.
Gli esperti americani segnalano poi la possibilità, per le Pratiche ad elevata conflittualità e con rischi di manipolazione, di organizzare incontri “congiunti” in cui le parti della coppia vengono collocati in stanze diverse e il team si sposta, così da evitare il confronto diretto tra i partner ed offrire un clima più sereno.
Vale poi la pena di sottolineare che la Pratica, pur intervenendo in aiuto alle famiglie per la prevenzione del conflitto, ha obiettivi in parte diversi rispetto alla mediazione familiare e la mediazione riparativa, che come abbiamo visto hanno destato le più allarmate riserve.
La Pratica Collaborativa aiuta infatti le parti a stabilire nell’immediatezza un piano di sicurezza, e in un secondo momento condizioni accettabili di separazione per la coppia e un giusto modo di essere genitori; il tutto nell’ottica di dare alla famiglia disgregata una regola accettata e condivisa dai suoi membri.
Non chiediamo invece alle parti di dimenticare il passato e di concentrarsi sul futuro; al contrario, l’esperienza passata, che non ha funzionato, deve essere valorizzata quale fonte da cui attingere le regole condivise che impediranno il ripetersi dei comportamenti negativi.
Non chiediamo nemmeno di comprendere la sofferenza dell’altro. Se ciò avviene, sarà un ulteriore passo avanti; ma l’accordo collaborativo può intervenire anche indipendentemente da questo passaggio emotivo. Possiamo insomma offrire un risultato forse meno interessante sotto il profilo dell’evoluzione della persona, ma pur sempre efficace nella riduzione della conflittualità.
Il non dover necessariamente affrontare questi nodi esistenziali comporta peraltro un vantaggio in termini di tutela della persona offesa, che non viene indotta a sperare in un cambiamento e quindi a scoprire il fianco a nuovi attacchi. Si cerca semplicemente un assetto adeguato alla gravità della situazione, con la costante attenzione a che le parti si sentano sempre libere nelle loro scelte ed in una situazione di comfort emotivo.
Ritengo altresì che la rinuncia a priori a ricercare soluzioni concordate sia un’occasione mancata – e in ultima analisi, una scelta poco saggia – se si paragonano i risultati nel tempo, in termini di costi emotivi ed umani, delle separazioni consensuali con quelle che sono regolamentate da una decisione del Giudice a seguito di contenzioso.
Immaginiamo per un attimo che la nostra famiglia altamente problematica e in disfacimento si rivolga al Giudice e deleghi il problema interamente allo Stato. Qual è la sensazione di un professionista che ben conosce la scarsa portata coercitiva delle sentenze in materia di famiglia?
È forse quella di maggior tranquillità per le sorti di quel nucleo? Crediamo davvero che l’Autorità Giudiziaria, più di noi avvocati, sia in grado di trovare le risposte giuste e di farle funzionare a dovere? È di questi giorni la condanna dell’Italia da parte della CEDU per non aver saputo offrire un’immediata ed efficace protezione ad una donna vittima di violenza domestica (noi Collaborativi parleremmo di “piano di sicurezza”).
Ancora. È forse la stigmatizzazione, l’etichettamento, la punizione la risposta giusta? Io personalmente mi sento molto a disagio nel rispondere affermativamente, e spiego il perché.
Prima obiezione: se una parte è consapevole che palesare una situazione di disagio porterà a delle conseguenze negative per il partner, per sé o per i bambini, sarà immediatamente portata a tacere finché può la situazione di disagio. Questo atteggiamento è estremamente pericoloso; eppure la nostra esperienza è nel senso che le persone deboli effettuano spesso la scelta di tacere per timore di come reagiranno i servizi sociali e il Giudice.
Immaginiamo, invece, di avere anche noi un obbligo di screening di violenza domestica al primo incontro col cliente e chiediamoci come il nostro approccio al problema cambierebbe. In effetti, molte delle nostre trattative si fondano su equivoci e/o omissioni, più o meno consapevoli, in cui nessuno di noi pare accorgersi dell’elefante nella stanza.
Seconda obiezione: che fine hanno fatto gli ordini di protezione civili? Forse che possiamo trasmettere al nostro cliente la fiducia nel fatto che il Giudice della separazione troverà, nel giro di pochi giorni, un buon piano di difesa mediante l’emanazione di un ordine di protezione?
Terza obiezione: se consigliamo di denunciare all’Autorità penale, che cosa otterremo? La nostra cliente riuscirà a sentirsi protetta dalla misura cautelare? O piuttosto la sua denuncia finirà nel calderone della “conflittualità familiare” che ormai molte Procure utilizzano per archiviare le notizie di reato? Che cosa deve subire una donna per essere creduta ed aiutata?
Ecco quindi che questi tre dilemmi portano a rivalutare la possibilità di lavorare diversamente, nell’ottica di ampliare il novero delle possibili risposte ad una richiesta di aiuto.
Sono consapevole che non è strada facile, né generalizzabile. Occorre, al contrario, estrema cautela nel proporla ai clienti. Amo però pensare che uno dei valori che un avvocato deve impegnarsi con maggior determinazione a ricercare nella sua professione sia la libertà del suo cliente. Sicuramente la libertà fisica e dalla violenza, ma anche la libertà morale, la libertà dal pregiudizio, la libertà da regole calate dall’alto che non si adattano alla sua vita, e che noi avremmo potuto contribuire a scrivere in modo diverso.
Amo pensare che la Pratica Collaborativa sia un modo per aiutare, nel nostro piccolo, le persone a raggiungere la loro libertà.