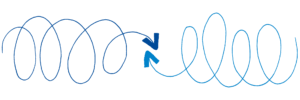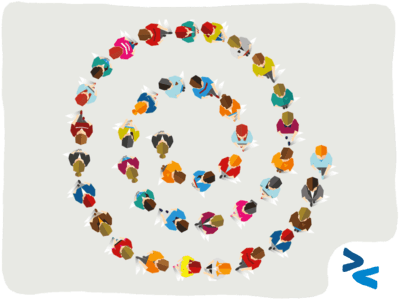La Pratica Collaborativa rappresenta per l’Italia una vera e propria sfida e una preziosa risorsa.
Da un lato, infatti, nel promuovere tale pratica dovremo vincere alcune importanti resistenze; dall’altro, essa risponde a un innegabile bisogno di risolvere in modo non contenzioso e duraturo nel tempo il numero sempre crescente di separazioni e divorzi che nella gran parte coinvolgono figli minorenni e comportano quindi anche la necessità di mantenere buone relazioni genitoriali. Al fine di contestualizzare il ragionamento che andrò a svolgere utilizzerò i dati più recenti, relativi a separazioni e divorzi, elaborati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pubblicati nel maggio 2013 e riferiti all’anno 2011.
Da essi risulta che nel 2011 in Italia le separazioni sono state 88.797 e i divorzi 53.806. Nel 1995 per ogni 1.000 matrimoni si contavano 158 separazioni e 80 divorzi, nel 2011 si è arrivati a 311 separazioni e 182 divorzi. Sempre nel 2011 si sono concluse in modo consensuale l’84,8% delle separazioni e il 69,4% dei divorzi.
L’età media della separazione è di circa 46 anni per i mariti e di 43 per le mogli, età che in caso di divorzio raggiunge rispettivamente 47 e 44 anni.
Più in generale le ultime rilevazioni Istat confermano che l’instabilità coniugale è in crescita, con separazioni più frequenti al Nord ma con un aumento maggiore al Sud; che la crisi colpisce maggiormente i quarantenni ma non risparmia gli ultrasessantenni; che in media ci si separa dopo 15 anni di matrimonio ma che i matrimoni più recenti durano sempre meno; che sono in aumento le separazioni di coppie miste, ossia formate da coniugi di nazionalità diversa; che la gran parte delle separazioni e dei divorzi avviene con procedura consensuale/congiunta; che in metà delle separazioni e in un terzo dei divorzi è coinvolto un figlio minorenne; che dal 2006, anno in cui è stata promulgata la legge cd. sull’affidamento condiviso, si è verificata una netta inversione di tendenza quanto all’affidamento che prima di allora era prevalentemente esclusivo a favore della madre (nell’80,7% delle separazioni e nell’82,7% dei divorzi nell’anno 2005) e che oggi è prevalentemente condiviso (nel 90,3% delle separazioni dell’anno 2011 a fronte di un residuo 8,5 % di affidamento esclusivo); che gli assegni di mantenimento per i figli vengono corrisposti nel 65,7% delle separazioni con figli che nel 57,6% delle separazioni avvenute nel 2011 la casa coniugale è stata assegnata alla moglie mentre appaiono quasi paritarie le quote di assegnazioni al marito (20,9%) e quelle che prevedono due abitazioni autonome e distinte ma diverse da quella coniugale (18,8%).
Le due associazioni nazionali
Nell’anno 2010 in Italia sono state costituite due distinte associazioni di livello nazionale, con l’obiettivo di diffondere la Pratica Collaborativa nel nostro paese: l’Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo (AIADC), con sede a Milano, e l’Istituto Italiano di Diritto Collaborativo (IICL), con sede a Roma.
L’AIADC, al luglio 2013, conta 137 soci di cui 111 avvocati, 17 esperti di relazioni familiari e 9 commercialisti, distribuiti soprattutto in Lombardia, Toscana e Piemonte, regioni dove sono stati organizzati corsi di formazione e dove quindi il numero dei professionisti formati è maggiore. In ciascuna di queste regioni è attivo un Practice Group che raggruppa i professionisti locali, soci dell’AIADC.
Nei primi due/tre anni di vita nell’ambito dell’AIADC i nostri sforzi sono stati indirizzati all’organizzazione di corsi di formazione, sia di primo livello che avanzati, per creare un numero sufficiente di professionisti tale da consentire, da un lato, di avviare casi gestibili con questa nuova modalità e, dall’altro, di avere sul territorio gruppi di “pionieri” per la diffusione della Pratica Collaborativa.
Per la formazione ci siamo avvalsi esclusivamente di professionisti stranieri, prevalentemente americani, con esperienza pluriennale nell’esercizio della Pratica Collaborativa e accreditati come formatori secondo gli Standard IACP. Potendo ormai iniziare a contare su un numero sufficiente di professionisti formati è giunto per noi il momento di individuare le modalità migliori per proporre ad un pubblico più vasto questo nuovo metodo di risoluzione delle controversie familiari ed è dunque cruciale capire come la cultura italiana e le peculiarità del paese condizioneranno la diffusione della Pratica Collaborativa, quali bisogni ed aspettative di clienti e professionisti italiani essa andrà a soddisfare e quali resistenze potrà incontrare.
Pratica collaborativa VS mediazione familiare
Una delle caratteristiche della Pratica Collaborativa che potrà avere grande presa sulle coppie italiane, e anche sulla classe forense, è rappresentata dal fatto che ciascuna parte affronterà il procedimento con l’assistenza di un proprio avvocato.
Questo è certamente molto rassicurante per il cliente che si accinge a separarsi e individua nell’avvocato il suo primo interlocutore, forse sopravvalutando il profilo legale del suo ben più complesso problema, composto da tanti altri aspetti, quali quelli finanziari, relazionali, di riorganizzazione della propria esistenza e dei rapporti parentali.
Per questo motivo la Pratica Collaborativa potrebbe avere più successo della Mediazione Familiare che nel nostro paese non ha avuto lo sviluppo e la diffusione che avrebbe meritato.
La distanza fra lo studio dell’avvocato e la stanza del mediatore, tipica della maggior parte dei modelli italiani di mediazione familiare, e la necessaria imparzialità del mediatore familiare hanno scoraggiato molte coppie dall’intraprendere o coltivare un percorso di mediazione familiare.
Nei modelli di mediazione familiare più diffusi in Italia, infatti, il contesto di mediazione è formato dalle parti e dal mediatore, senza l’assistenza e la copresenza degli avvocati ai quali le parti sono inviate nei momenti in cui sia opportuna una consulenza di carattere legale o sia necessario, al termine del percorso di mediazione, redigere un atto legale da presentare davanti all’autorità giudiziaria. Durante il percorso di mediazione familiare, salvo questi momenti, gli avvocati sono invitati a mantenersi defilati nel rispetto della cd. tregua giudiziaria.
In tali modelli il mediatore familiare si pone come terzo neutrale rispetto alle parti e spesso tale neutralità, per alcune coppie e in certe fasi della separazione, è difficile da sostenere.
La partecipazione degli avvocati alla Pratica Collaborativa è elemento per il quale anche la classe forense potrà accogliere con favore questo metodo di risoluzione dei conflitti al contrario di quanto una parte dell’avvocatura ha fatto rispetto alla Mediazione Familiare, soprattutto nella sua prima fase, quando quest’ultima è stata considerata una pericolosa alternativa all’attività stragiudiziale dell’avvocato.
Le resistenze
Se quello appena descritto è il punto di maggior forza che possiamo prevedere nell’accettazione della Pratica Collaborativa in Italia, dobbiamo però ipotizzare più di una resistenza che è necessario prepararci a vincere.
Le maggiori resistenze saranno rappresentate da specifiche caratteristiche della cultura, non solo giuridica, dell’Italia.
Proverò a prevederne alcune.
Innanzitutto in Italia, paese considerato da sempre culla del diritto, è molto radicato il concetto della risoluzione dei conflitti secondo il parametro legale, non solo nel cittadino che si rivolge al professionista per avere risposta al suo problema che, infatti, pone nei termini Quali sono i miei diritti? ma anche nell’avvocato che, nel rispondere a tale domanda, è abituato a fare riferimento solo alle norme e all’interpretazione che di esse offre la giurisprudenza consolidata.
Non sarà affatto facile per l’avvocato italiano, più ancora che per il cliente, ragionare secondo la nuova logica per cui il diritto costituisce una, non l’unica, delle possibili opzioni, con la quale risolvere la controversia.
Tutta la formazione universitaria del futuro avvocato italiano ed anche il successivo tirocinio sono impostati secondo la cultura tradizionale di risoluzione del conflitto basata sui “core beliefs” così ben illustrati da Julie Macfarlane nel libro “The New Lawyer. How settlement is Transforming the Practice of Law”, ossia
- la supremazia della soluzione basata sui diritti (“The Default to Rights”)
- il processo legale come sinonimo di giustizia (“Justice as Process”)
- la delega all’avvocato come persona incaricata di risolvere la questione (“Lawyers in Charge”).
Anche se da molti avvocati è avvertita la necessità di un cambiamento di mentalità e d’identità, da “avvocato combattente” a “avvocato risolutore di conflitti”, non è facile la realizzazione effettiva di un simile passaggio quando la formazione obbligatoria di base e l’esperienza pluriennale sono state impostate in modo completamente diverso e il nuovo poggia su una formazione fresca e necessariamente ben più breve, che rappresenta scelta del tutto volontaria e “di nicchia”, per lo più non ancora sedimentata e consolidata attraverso ripetute esperienze di casi pratici.
Noi avvocati italiani che vogliamo esercitare la Pratica Collaborativa e diffonderla dovremo dunque lavorare prima di tutto moltissimo su noi stessi, per vincere le nostre resistenze all’applicazione pratica del nuovo che teoricamente ci affascina e che a quel livello di pura teoria accettiamo completamente, nella piena consapevolezza di una formazione e di una mentalità che naturalmente ci porterebbero a risolvere la controversia secondo i parametri tradizionali.
Prima ancora di convincere i nostri clienti dovremo essere convinti noi stessi professionisti di quanto sia innanzitutto importante porsi la domanda How? rispetto a quella What?
Pratica collaborativa VS trattativa tradizionale stragiudiziale
Proprio dalla non consapevolezza di quanto diverso sia sostanzialmente il ruolo del diritto e il ruolo dell’avvocato nella Pratica Collaborativa rispetto alla trattativa stragiudiziale tradizionale nasce anche un’ulteriore criticità che peserà sulla diffusione della nuova modalità nella classe forense.
Molti avvocati italiani non formati alla Pratica Collaborativa, che da anni affrontano le controversie familiari con spirito conciliativo e in un’ottica multidisciplinare, quando sentono parlare di questa nuova modalità di risoluzione dei conflitti familiari, esclamano “Io la pratico da sempre!”, non rendendosi conto che si tratta di tutt’altro dalla trattativa tradizionale stragiudiziale, pur quando quest’ultima sia condotta in modo eccellente.
In effetti, senza essere passati almeno attraverso l’esperienza di un corso di formazione base alla Pratica Collaborativa, può sfuggire la fondamentale differenza che vi è fra la gestione di una separazione mediante la trattativa condotta da due abili ed esperti avvocati secondo l’approccio tradizionale e la gestione della stessa separazione nell’ambito della procedura collaborativa.
In entrambi i casi il risultato, se positivo, sarà la redazione di un ricorso per separazione consensuale ma il percorso per arrivarvi sarà stato completamente diverso.
All’inizio di questo lavoro ho evidenziato come sia alta la percentuale di separazioni consensuali in Italia e ciò rappresenta certo il frutto dell’ottimo lavoro di avvocati, spesso specializzati nella materia, che sanno individuare le condizioni per giungere ad un accordo, attraverso trattative pazienti fino ad oggi condotte secondo i metodi tradizionali.
Persino per gli avvocati formati alla Pratica Collaborativa è spesso più facile affrontare una controversia familiare con gli strumenti conosciuti e collaudati piuttosto che avventurarsi con i nuovi, da poco appresi in teoria e non sperimentati.
Pertanto sarà cruciale nel diffondere la Pratica Collaborativa evidenziare le rilevanti differenze di questa rispetto alla trattativa tradizionale che conduce ad un accordo di separazione, molto più che rispetto al contezioso giudiziario i cui tratti distintivi sono evidenti a tutti e facilmente comprensibili.
Una limitazione alla creatività?
Dobbiamo anche considerare che proprio una delle più importanti differenze fra trattativa tradizionale e Pratica Collaborativa potrebbe essere vissuta dall’avvocato italiano come una sorta di limitazione alla sua “creatività”.
Ci riferiamo al fatto che la trattativa tradizionale è lasciata alla discrezionalità, alla personalità e allo stile di ciascun professionista, non trattandosi di procedura strutturata che deve seguire precise fasi condivise, per le quali siano previste regole, obblighi, sanzioni.
L’avvocato italiano, certo molto meno pragmatico del collega americano, potrebbe vivere con una certa insofferenza la necessità di osservare una procedura ben precisa, contraddistinta da varie fasi, tutte ugualmente importanti (la cd. coreografia).
Dunque sarà essenziale far capire che proprio dall’osservanza rigorosa della procedura consegue la soluzione positiva del caso e che tale rigore non penalizza, ma semmai esalta, l’abilità e lo stile propri di ciascun professionista.
La sfida del lavoro in squadra
Un’altra sfida sarà certamente rappresentata dalla poca abitudine del professionista italiano a lavorare in squadra e dall’individualismo tipico dell’avvocato italiano, capace di proporsi come eccellente solista ma poco propenso a confondere la propria voce all’interno di un’orchestra.
Noi italiani dovremo sviluppare la nostra capacità di lavorare in team multidisciplinare e non accontentarci di un modello di pratica collaborativa a 4 (parti e avvocati). È incoraggiante il fatto che nei diversi Practice Group emerge chiaramente l’importanza del ruolo dell’esperto di relazioni familiari nel team collaborativo non solo per rispondere agli specifici bisogni della coppia ma quale facilitatore della comunicazione e delle dinamiche relazionali di tutti i componenti del team stesso.
La trasparenza
Una notevole resistenza alla gestione di un caso con la Pratica Collaborativa sarà probabilmente rappresentata anche dall’obbligo che le parti assumono di mettere reciprocamente a disposizione ogni informazione e documento utile per prendere le decisioni con piena consapevolezza delle circostanze di fatto. Soprattutto da un punto di vista economico il cliente italiano è spesso restio a dichiarare e documentare tenore di vita ed effettivi redditi e gli avvocati italiani sanno bene quanto anche in sede contenziosa sia spesso impresa davvero ardua riuscire a provare la reale consistenza economica di alcune controparti particolarmente benestanti che spesso occultano le loro reali risorse.
Per convincere i clienti ad assumere e mantenere l’impegno di offrire lealmente tutte le informazioni necessarie è fondamentale garantire la riservatezza del procedimento collaborativo.
Al momento non abbiamo in Italia una legge che disponga simile privilegio in riferimento alla Pratica Collaborativa, come del resto non vi è una legge che lo preveda per il percorso di Mediazione Familiare che pure si basa su analogo presupposto.
È allora cruciale approfondire se l’impegno contrattuale preso dalle parti con l’Accordo di partecipazione possa, e in quali limiti, garantire la riservatezza di quanto dichiarato e prodotto durante il procedimento collaborativo e quali conseguenze abbia il suo eventuale inadempimento.
C’è da chiedersi, ad esempio, se all’utilizzo di un documento riservato nell’eventuale giudizio contenzioso consegua l’inammissibilità della prova, perché illecita, o la mera tutela risarcitoria.
Il fatto che le parti vengano direttamente a conoscenza delle dichiarazioni e dei documenti che reciprocamente scambiano fra loro rende più complessa la questione rispetto alla trattativa tradizionale tra gli avvocati senza la presenza dei rispettivi clienti.
Gli avvocati, infatti, sono vincolati al principio della riservatezza dal Codice Deontologico Forense che all’art. 9 prevede il “Dovere di segretezza e riservatezza”, all’art. 28 il “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega” e all’art. 58 dispone che “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto….”.
Tale dovere deontologico dovrebbe valere sia nei confronti del cliente che dell’altra parte.
Se è necessario garantire la riservatezza della Pratica Collaborativa è d’altra parte indispensabile non privare le parti del diritto di provare i fatti nell’eventuale giudizio contenzioso che dovesse seguire al fallimento della procedura Collaborativa. La parte deve mantenere il diritto, ad esempio, di chiedere al giudice l’ordine di esibizione di documenti all’altra parte e al terzo ai sensi del codice di procedura civile.
Nessun problema se si tratta di un documento di cui la parte richiedente era già a conoscenza a prescindere dal procedimento collaborativo. Ma se si trattasse, invece, di un ricco dossier titoli che l’altra parte ha mostrato durante il procedimento Collaborativo, non altrimenti conoscibile?
Sul tema della riservatezza gli aspetti problematici dovranno essere approfonditi col supporto della Dottrina e con il coinvolgimento degli Ordini Professionali e della Magistratura, anche al fine di prevedere, attraverso protocolli d’intesa, prassi virtuose che vincolino tutti i protagonisti anche dell’eventuale giudizio contenzioso.
La fiducia di AIADC
Nell’AIADC siamo consapevoli che la diffusione in Italia della Pratica Collaborativa potrà presentare criticità e incontrare importanti resistenze ma siamo altrettanto convinti della necessità di evitare facili adattamenti che ne mortificherebbero il significato. Abbiamo piuttosto l’ambizione di lavorare per provocare un cambiamento culturale nel nostro paese che consenta di vincere le resistenze descritte e di accogliere la Pratica Collaborativa mantenendone intatto tutto il potenziale innovativo. E siamo fiduciosi di riuscirci!